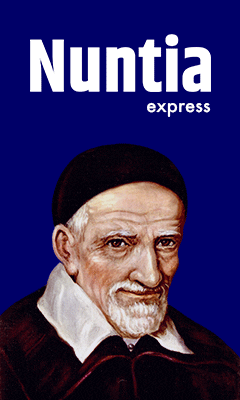Il nome
Vari sono i nomi o titoli degli istituti religiosi. Ci son istituti che ricordano il fondatore (benedettini, francescani, domenicani, filippini), altri il luogo di fondazione (premostratensi, camaldolesi), altri la regola che seguono (agostiniani), altri una devozione (Trinità, Assunzione, Croce, Passione, Immacolata, Spirito Santo), altri un programma di vita (servi/e, figli/e, operai/operaie), altri l’opera (fratelli delle scuole cristiane, maestre pie per l’infanzia).
Noi figli di S. Vincenzo siamo chiamati dalla gente vincenziani, paúles, lazzaristi. Ma il nome scelto da Vincenzo è invece quello di Congregazione della Missione e per i suoi membri di missionari o preti della missione.
Noi siamo la Missione. Siamo stati i primi a scegliere questo titolo e per questo Vincenzo vide di malavoglia che dei preti di Genova si chiamassero missionari (III, 356). Le nostre case dovevano chiamarsi Casa della Missione (VIII, 553).
La scoperta
La Missione non l’aveva nel sangue. Fu una scoperta. A Folleville si sentì “mandato”. Il discorso di Folleville fu il primo discorso della Missione (I, 2-5). In quella piccola Chiesa sperduta nel verde della Piccardia il santo ricevette in dono la vocazione ad andare.
Vincenzo e i suoi primi compagni si sentirono come i servi del Vangelo. Essi cominciarono ad evangelizzare nei feudi dei Gondi, poi lo spirito della missione li costrinse ad uscire e percorre città e campagne della Francia, poi dell’Italia, della Polonia, ad attraversare travestiti le Isole britanniche e raggiungere infine il Madagascar e il mondo intero.
Questa vita era una vita di pericoli e di rinunce per i protagonisti, ma anche di grande dolore per lui: «Preghiamo per padre Bourdaise, fratelli, padre Bourdaise, che è lontano e così solo e, come avete saputo, ha generato a Gesù Cristo con tanta pena e tanta fatica un gran numero di anime nel paese dove si trova. Padre Bourdaise, sei ancora in vita o no? Se lo sei piaccia a Dio conservartela ancora! Se sei in paradiso, prega per noi! O fratelli, qual felicità per la Compagnia, avere persone così buone, come quei suoi servi di cui ho parlato! E’ così, fratelli, è in questa disposizione che dobbiamo stare noi tutti, pronti e disposti a lasciar tutto per servire Dio e il prossimo, e il prossimo, badate, e il prossimo per amor di Dio” (XII, 69).
Il dono
Vincenzo faticò a capacitarci di aver avuto una vocazione così alta, una continuazione di quella di Gesù: «Far conoscere Dio ai poveri, annunziare loro Gesù Cristo, dir loro che il regno dei cieli è vicino ed è per loro. Quanto è grande! L’essere chiamati a partecipare e condividere la missione del Figlio di Dio sorpassa il nostro intendimento. Ma come! Essere resi … Non oso neanche dirlo. Insomma è una missione tanto sublime quella di evangelizzare i poveri, che è, per eccellenza, la missione del Figlio di Dio; e noi siamo coinvolti come strumenti, grazie ai quali egli continua a fare dal cielo quello che fece sulla terra. C’è gran motivo, fratelli, per lodare Dio e ringraziarlo continuamente di questa grazia!” (XII, 80).
Il dono ricevuto della Missione implica azione: « Apparteniamo a lui e non a noi stessi. Se aumenta il nostro lavoro, egli aumenterà anche le nostre forze. O Salvatore! Quale felicità! O Salvatore, se vi fossero molti paradisi a chi li daresti se non ad un missionario che sia stato fedele a tutte le opere che gli hai indicato, senza venir meno ai doveri del suo stato? E’ quanto speriamo, fratelli, e lo chiediamo alla sua divina Maestà” (XII, 93s.).
Lo scandalo
Nel ‘600 c’era una società sottomessa, in cui il re e la corte vivevano come in un altro mondo, in cui si ammirava l’aristocrazia e in cui vigeva un autentico anche se non dichiarato apartheid. Ora per il popolo nasceva un problema grave in quanto non conosceva le verità necessarie alla salvezza: «voi sapete quanto sia grande l’ignoranza del povero popolo: quasi da non credere! E sapete che non c’è salvezza per le persone che ignorano le verità cristiane necessarie da sapersi, ossia secondo l’opinione di sant’Agostino, di san Tommaso e di altri, i quali dicono che una persona, che non conosca né il Padre, né il Figlio, né lo Spirito Santo, né l’Incarnazione, né gli altri misteri, non si può salvare» (XI, 80). In più questo popolo si scontrava con un clero che non conosceva nemmeno la formula dell’assoluzione, che non predicava e quindi non insegnava le verità necessarie alla salvezza. A tali lacune si aggiunga il fatto che «molta gente non fa buone confessioni e tace consapevolmente peccati mortali, dimodoché l’assoluzione non è valida e, morendo in tale stato, sono dannati per sempre» (XI, 82).
Per questo aveva chiesto al suo rappresentante a Roma, du Coudray di rivolgersi al papa Urbano VIII: «Deviriuscire di fare capire [al papa] che la povera gente si danna non conoscendo ciò che è necessario alla salvezza e non confessandosi. Se sua Santità conoscesse tale necessità, non troverebbe riposo e farebbe tutto il possibile per rimediarvi. È proprio l’averne fatto esperienza, che ci ha fatto fondare la compagnia per porvi rimedio almeno in parte» (I, 115).
Vincenzo sapeva che fra i teologi si discuteva delle verità necessarie alla salvezza, cioè Unità e Trinità di Dio, Incarnazione e vita eterna. Era per lui facile, nel dubbio, farsi da parte quando i poveri rischiavano la salvezza eterna? Era giusto che chi aveva vissuto l’inferno sulla terra se lo ritrovasse nell’eternità? Potevano i poveri salvarsi senza fede, speranza e carità?
Salvatore e salvatori
Nel 1658 Vincenzo scrisse una lunga lettera ad Antonio Fleury, che si trovava a Saintes, dove c’erano molti protestanti. Non era facile per i cattolici vivere la loro fede in simili condizioni. Il santo ricordava che «secondo la via ordinaria, Dio vuole salvare gli uomini per mezzo degli uomini, e Nostro Signore si è fatto uomo egli stesso per salvarli tutti» (VII, 340s.). Il missionario era pertanto chiamato a partecipare a quest’opera di Gesù Cristo, ad essere come Gesù Cristo: «Oh, quale felicità per te essere adoprato per fare ciò che egli ha fatto! È venuto ad evangelizzare i poveri, ed è questa la tua sorte e la tua occupazione» (VII, 341).
Vincenzo aveva ripetuto più volte che «Non mi basta amare Dio se il mio prossimo non lo ama» (XII, 262). I missionari pertanto devono essere «salvatori come lui» (XII,113). Ricordava pertanto a Fleury: «Se la nostra perfezione si trova nella carità, come è sicuro, non ce n’è una più grande che dare se stessi per salvare le anime e consumarsi come Gesù Cristo per loro. Ecco a che cosa sei chiamato, ed a che cosa devi essere disposto a corrispondere» (VII, 341). Occorre che la vita del missionario sia una vita di oblazione, una vita di carità (XI, 413). Egli pertanto dovrebbe essere un esempio vivente «a tanti e tanti ecclesiastici che sono altrettanti operai mandati nella vigna del Signore, ma che non la lavorano!» (VII, 341). Chi ha la vocazione missionaria deve essere «essere crocifisso con Gesù Cristo e porre in lui solo le proprie gioie e le proprie aspirazioni» (VII, 342). È necessario pertanto essere conformi a Gesù Cristo (XII, 113), per divenire suoi cooperatori (XI, 108).
Un tempo i missionari si caratterizzavano per un abito. Ma, lo sappiamo, l’abito non fa il monaco o il missionario. Se il p. Generale ci chiama alla missione è per ricordarci di rivestire quell’abito di luce che caratterizza i servi del Vangelo. L’abito della missione è un abito tessuto di spirito in quanto «lo Spirito, risiedendo in questa persona, le conferisce le medesime inclinazioni e disposizioni che Gesù Cristo aveva sulla terra» (XII, 108). E con quest’abito i missionari potranno andare non solo ai confini del mondo, ma della vita. E oltre.
P. Luigi Mezzadri CM
Provincia d’Italia